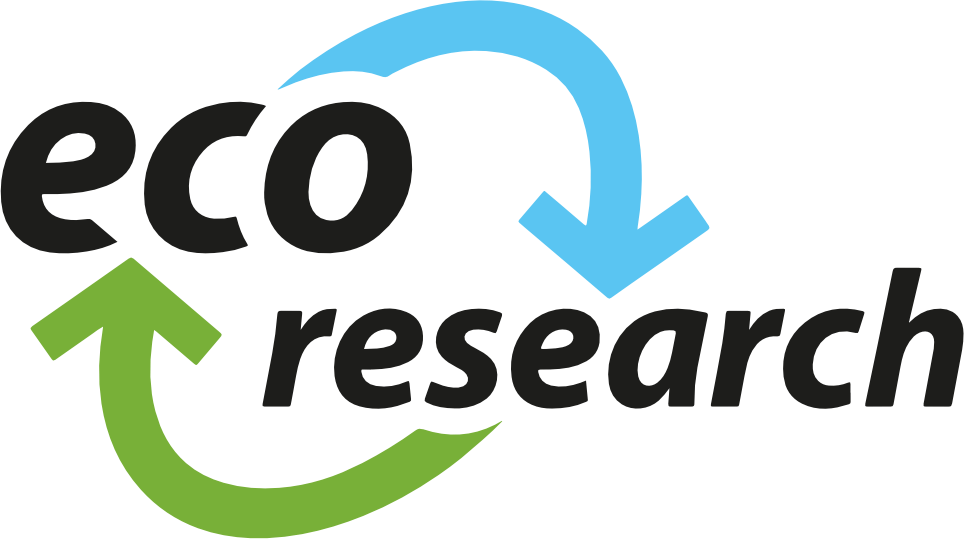Rimozione di microplastica dalle acque reflue urbane: uno studio sull’efficienza degli impianti di depurazione
La produzione globale di plastica negli ultimi decenni è aumentata significativamente, e con essa le problematiche legate ai rifiuti plastici. Un problema ambientale sempre più urgente da affrontare è quello legato alla dispersione di micro- (e nano-) plastiche. Si tratta di particelle di diametro inferiore a 5 mm, derivanti dalla frammentazione di prodotti o rifiuti in plastica. Oltre a rappresentare un rischio per l’ambiente e la salute umana data la loro persistenza in ambiente, possono anche veicolare patogeni o rilasciare altre sostanze inquinanti. In un contesto urbano, la loro presenza nelle acque reflue è prevalentemente dovuta agli scarichi domestici ed al dilavamento delle strade. Dato che queste acque sono soggette al trattamento presso appositi impianti, è importante controllare se gli attuali stadi di trattamento sono sufficienti per la rimozione della microplastica.
Questo è stato l’obiettivo di un nuovo studio, frutto della collaborazione tra Università di Trento, Università di Firenze, Eco Research ed Eco Center. La ricerca, condotta presso un locale impianto di depurazione delle acque, ha monitorato la quantità e tipologia di microplastiche di dimensioni comprese tra 10 e 5000 μm presenti nei vari stadi del processo di trattamento, utilizzando tre tecniche analitiche complementari: spettroscopia FTIR, spettroscopia LDIR e TD-GC/MS.
I risultati mostrano che gli impianti di depurazione sono in grado di rimuovere oltre il 96% delle microplastiche presenti nelle acque reflue, concentrandole tuttavia nei fanghi di depurazione. Questi a loro volta possono diventare una fonte di rilascio delle particelle in ambiente, un aspetto non trascurabile dato il loro potenziale utilizzo come fertilizzanti in agricoltura. Pertanto, è necessario adottare strategie mirate per una loro gestione e riutilizzo sostenibile, ad esempio inserendo degli stadi di abbattimento della microplastica presente nei fanghi (incenerimento o pirolisi) nel processo, in modo da bloccarne la re-introduzione in ambiente.
A B S T R A C T
This study investigated microplastics (MPs) sized 10–5000 µm across stages of a conventional municipal wastewater treatment plant using multiple analytical techniques. Samples were collected via pumping and filtration, treated with the Fenton reaction for wet peroxidation, and separated by density separation. Analysis employed Focal Plane Array Micro-Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FPA micro-FTIR), a widely used technique in MPs analysis, alongside the less common Laser Direct Infrared Spectroscopy (LDIR), providing complementary data on particle composition, shape, size, and colour. To enhance insights, spectroscopic methods were supplemented with Thermal Desorption Gas Chromatography-Mass Spectrometry (TD-GC/MS), calibrated for specific polymers, to quantify MPs by mass and assess removal efficiency. Wastewater treatment effectively reduced MPs. In influent samples, concentrations reached 72 MPs/L (FTIR), 2117 MPs/L (LDIR), and 177 µg/L (TD-GC/MS). Primary treatments removed 41 %–55 %, while the wastewater treatment plant effluent contained 1 MPs/L (FTIR), 93 MPs/L (LDIR), and 2 µg/L (TD-GC/MS), reflecting 96 %–99 % removal efficiency. Activated sludge showed concentrations of 123 MPs/L (FTIR), 10,800 MPs/L (LDIR), and 0.3 mg/g dry weight (TD-GC/MS), underscoring its role in MPs capture. However, sludge dewatering released significant MPs into centrifuge rejected water: 484 MPs/L (FTIR), 23,000 MPs/L (LDIR), and 1100 µg/L (TD-GC/MS). These results highlight the effectiveness of conventional treatments in MPs removal and the critical role of sludge in capturing these contaminants. However, sludge dewatering poses a risk of reintroducing MPs into the environment. Effective sludge management should prioritize nutrient recovery and biomass valorisation to mitigate these risks and minimise harmful environmental impacts.